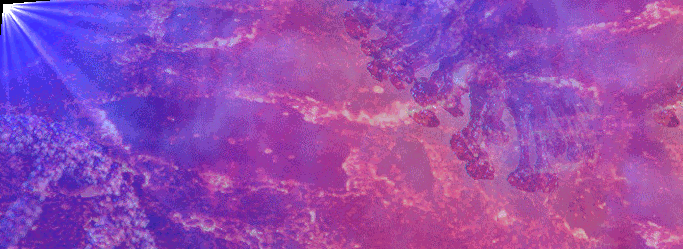Personalmente leggo di storia per sottrarmi alla tentazione di vivere il presente come l’unica dimensione temporale che ci è data. La consapevolezza di essere un anello infinitesimale della catena che moltitudini di uomini intrecciano da millenni, se per un verso immalinconisce, offre tuttavia un appiglio di senso all’esistenza del singolo. Di recente ho dunque riletto le Vite dei dodici Cesari di Svetonio, uno storico della romanità imperiale, considerato minore per non aver saputo andare oltre l’esposizione aneddotica, per non essere cioè stato capace di “pensare” le vicende che racconta.
L’avvio della narrazione è comunque esaltante, forse anche per la grandezza dei personaggi che occupano la scena, mentre si fa piatta e pettegola a lungo andare, quando le piccinerie della corte, pur crudeli, si ripetono eguali. Successione di fatti e dicerie che a volte illuminano l’uomo, ma che spesso restano elenco di episodi. Non mancano malignità - o disprezzo? - anche per Cesare e Augusto (dei rimanenti, da Tiberio a Nerone, l’universale già sparlava senza ritegno). Un libro comunque da leggere, per la massa di informazioni di prima mano che contiene.
Annoto impressioni epidermiche: la gente della Roma imperiale (plebe, ma non solo), nominalmente padrona del mondo ma nei fatti priva di qualsiasi peso politico, pensava ormai solo ai giochi, che si rinnovavano e celebravano a ogni occasione sempre più fastosi e spettacolari: gladiatori, belve, corse di cocchi, fin battaglie navali - e poi teatro. Partecipavano da attori nobili e donne, che mai era avvenuto prima, sazi fino al disgusto di una vita a cui non sapevano più cosa chiedere. Una società corrotta dal profondo: la moltitudine mangiava per distribuzioni gratuite, mentre i nobili si disputavano cariche prive di potere reale e celebravano trionfi senza aver mai combattuto. L’apparenza della gloria avrebbe dovuto mascherare la precarietà del vivere accanto al principe tiranno.
Il quale iniziava sempre ingraziandosi tutti - ma per primi i pretoriani e le legioni - con donativi in denaro, cibo e, s’è detto, giochi senza fine, apparenza di umanità, giustizia, benevolenza per l’universale. Poi, saldo il potere, la musica cambiava. Questi Cesari parevano diventare tutti pazzi, fosse l’onnipotenza incontrastata, la consapevolezza di non poter fidarsi d’alcuno, la noia dell’aver tutto ancor prima di desiderarlo.
Ma la storia è uno specchio nel quale, lo si voglia o no, si riflette il secolo che viviamo - del resto Croce affermava paradossalmente che la storia è sempre contemporanea. Leggendo dei Cesari pensavo al tempo di oggi e alla blandizia subdola dei governanti di un recente passato, i vari principi che ci siamo dati (tralascio i nomi, che sono nella memoria di ciascuno) e ai giochi televisivi distribuiti a profusione e i premi promessi o fatti intravedere e il calcio gladiatorio che tutto sopravanza e l’arrivismo individualistico alla ricerca di una porzione di potere all’interno della gerarchia del denaro. E gli adulatori sfrontati, pur colti e intelligenti, che non si vergognano di nulla: fin di negare l’esistenza della luce credendo di consolidare il principe sul cocchio e promuovergli consenso - e acquisire pelosa riconoscenza per sé. Prebende, tangenti, pensioni d’annata hanno sostituito le distribuzioni di grano e di vino - e gli incarichi consolari a chi non ha bisogno di pane. Il video s’apre ai notabili di oggi che vogliano recitare una qualsivoglia parte che li veda se non protagonisti, almeno ragazzi del coro o ballerine di fila. Capisco d’essere fra i molti di cui Machiavelli dice (con sarcasmo, ironia, compatimento?) “si sono immaginati repubbliche e principati che non si sono mai visti né conosciuti essere in vero”. Ma non posso fare a meno di rimuginare questi raffronti.
Consola l’uomo della strada, quidam de populo, il leggere come tutto infine ruini - prepotenza, ricchezza, spudoratezza - nella morte politica o comunque fisica e storica. Consolazione sufficiente? Gli spazi di libertà tuttavia nei secoli si ampliano e vi partecipano sempre maggiori moltitudini. Ma la strada ancora non mostra l’arrivo, l’utopia essendo sempre utopia: l’individuo troppo spesso costretto a morire rifiutando il consenso e consegnando ai nipoti la speranza, pago del solo patrimonio della dignità personale salvaguardata nonostante le tentazioni e gli sberleffi del secolo.
DEL PRINCIPE, a cura di a.s.
Una città non si poteva chiamare libera dove era uno cittadino che fusse temuto dai magistrati (Machiavelli)
La potenza fondata sulle amicizie conduce a commettere ingiustizie (Plutarco)
Aver stimato più il regnare che l’osservanza della fede (Guicciardini)
Per essere gonfio di boria mi credevo grande (Agostino)
Così menano la loro vita come in scena, dove un personaggio si è dentro e un altro si rappresenta di fuori (Daniello Bartoli)
Dall’unghia si riconosce il leone (Saramago)
Sappia che si esige di più da quelli a cui fu più affidato (Benedetto da Norcia)
Perché ei (il principe) non può mai spogliare uno tanto che non gli rimanga uno coltello da vendicarsi (Machiavelli)
Questi sarà sorpreso per la sua iniquità: ma della sua morte domanderò conto alla sentinella (Ezechiele)