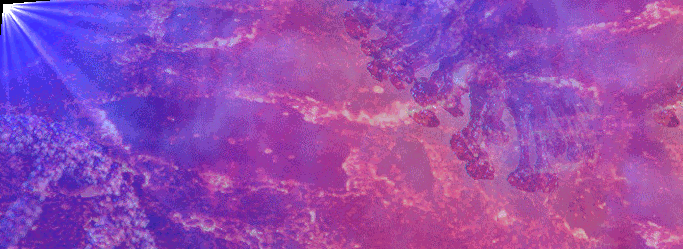Introduzione
L’esistenza degli istituti penitenziari di internamento (soprattutto quelli che non hanno teoricamente rapporto con la malattia mentale) e il concetto di pericolosità sociale hanno da sempre occupato una posizione controversa che inevitabilmente ha alimentato rivendicazioni e polemiche più o meno legittime.
A ben vedere la distinzione tra istituti penitenziari d’internamento per malati mentali e per criminali “sani di mente” è più fittizia che reale nonostante proprio sulla base di questa distinzione si costruiscano linee di difesa processuali e destini individuali. Tale distinzione è generata dal misconoscimento di conoscenze psicologiche che dovrebbero ormai essere da tempo consolidate. Non si capisce perché alcuni disturbi mentali vengono considerati tali, mentre altri disturbi mentali forse meno eclatanti, ad esempio il disturbo di personalità antisociale o la perversione, non vengono riconosciuti come disturbi mentali a tutti gli effetti. Questo atteggiamento sorprende perché basterebbe aprire il banalissimo DSM IV-R, universalmente utilizzato, per scoprire che tutte queste diverse manifestazioni psicopatologiche rientrano a pieno titolo nella categoria dei disturbi mentali. Qualcuno potrebbe ipotizzare che questi sono più gravi di quelli. Ma anche dal punto di vista della strutturazione, della stabilizzazione, della resistenza al cambiamento e degli effetti nocivi su di sé e sugli altri il disturbo di personalità antisociale e la perversione non hanno nulla da invidiare neppure alle psicosi e alle schizofrenie più scompensate. Anzi, mentre un antipsicotico produce spesso effetti di compenso significativi non esistono farmaci, psicoterapie o altre forme di intervento che producano effetti sensibili nei soggetti antisociali e perversi.
Questo misconoscimento produce effetti indesiderati a molti livelli, da quello giudicante, a quello del rapporto tra istituti penitenziari (ad esempio tra Opg e case di lavoro), tra istituti penitenziari e altri enti (ad esempio con le Ausl o con la Magistratura), tra operatori all’interno dello stesso istituto penitenziario. Diventa infatti difficile adottare percorsi di sostegno al soggetto internato condivisi e armonici, complicando così un iter già critico e pieno di insidie per sua natura. Queste considerazioni sono intimamente connesse con un altro pregiudizio psicologico faragginoso ma estremamente rilevante dal punto di vista giuridico: la capacità di intendere e volere. Non affronterò in questo contesto la questione nel suo complesso ma è del tutto evidente che viene ipotizzato uno stretto rapporto tra “vere malattie mentali” e la capacità d’intendere e volere. Le “vere malattie mentali” sarebbero quelle dove non è reperibile la capacità d’intendere e volere. Mi limito a rilevare che nessuna forma psicopatologica viene agita da un soggetto con piena capacità d’intendere e volere benché sia necessario ipotizzare, al cuore di ogni soggetto, un punto libero da patologia che gli consentirebbe di scegliere, se lo “volesse”, di determinarsi anche in modo non patologico. Tuttavia, una cosa è sostenere che qualunque soggetto ha la possibilità, per quanto remota, di uscire dalla propria patologia e un altra è affermare che un soggetto patologico, in quanto tale, sia capace d’intendere e volere; se lo fosse non sarebbe patologico. Trovo utile articolare la riflessione sulla pericolosità sociale a partire da due considerazioni distinte:
1. il danno sociale, cioè la necessità di proteggere cittadini innocenti;
2. l’esigenza di aiutare il criminale verso il cambiamento del proprio mondo interno ed esterno.
I due aspetti sono per un verso connessi perché modificare la struttura interna del criminale in modo che possa vivere all’interno della società senza commettere crimini ha evidentemente un effetto rilevante anche sul fine di proteggere il cittadino innocente, ma possono anche essere in opposizione reciproca perché il bisogno di protezione del cittadino può richiedere l’allontanamento dalla società del criminale che pur avendo scontato la pena non abbia mostrato alcun segno di cambiamento strutturale rimanendo ancora potenzialmente un uomo che commette reati più o meno gravi per vivere. Ecco così che ci troviamo al cuore della delicata questione concernente l’istituzione dell’internamento nel nostro ordinamento giuridico dovuto alla valutazione della pericolosità sociale. Infatti è impossibile accertare in modo apodittico che un uomo sia oppure no pericoloso socialmente; così, è difficile sostenere giuridicamente la necessità di privare della libertà qualcuno che ha già scontato la pena per i reati commessi ma che potrebbe probabilmente commetterne altri limitando la libertà e la serenità di cittadini innocenti. Esiste un’ampia polemica causata dall’insoddisfazione del sistema giudicante che rigetta la prospettiva probabilistica nella speranza di una certezza, confusa con “scientificità”, che può essere solo un’aspirazione ideale o una costruzione artificiale non realistica.
D’altronde spesso accade che l’internato pericoloso proprio durante la messa alla prova all’esterno commetta reati anche gravi. E’ estremamente difficile tutelare contemporaneamente i diritti dei cittadini e quelli del reo che ha già scontato la pena e che fino a prova contraria, per quanto improbabile, potrebbe sempre non commettere altri reati nonostante tutte le difficoltà interne ed esterne. Come muoversi? Vado oltre. Se anche fosse possibile accertare di qualcuno l’assenza di sensibili cambiamenti interni e il permanere in uno stato di devianza stabilizzata e strutturata (ad esempio in ogni soggetto che ha una diagnosi di disturbo di personalità antisociale o di perversione) come ci si dovrebbe regolare? Dato che permane in uno stato di pericolosità non modificato è legittimo privare all’infinito lo stato di libertà di un soggetto che oggettivamente, perché contenuto, non ha più commesso reati che giustificherebbero la sua detenzione? Credo che sia una domanda che dobbiamo porci. La legge italiana è come se partisse dall’ingenuo presupposto che un intervento anche abbastanza modesto e composto prevalentemente dal reinserimento sociale e dal lavoro all’esterno possa modificare la vita e la personalità degli internati. Ma purtroppo ciò non è vero. Se ciò avvenisse sarebbe un miracolo e la giustizia non può procedere appellandosi ai miracoli. Noi sappiamo che non è così e che anche quando è presente una forte motivazione al cambiamento, risorsa rarissima nelle carceri, è necessario un lavoro molto lungo ed impegnativo per cambiare qualcosa della struttura di un soggetto. Cosa fare allora?Protezione sociale
Diciamo apertamente e senza ipocrisia che, come tutti sanno, la maggior parte dei criminali in libertà tornano nuovamente a commettere i reati per i quali sono stati reclusi. La nuova legge sull’indulto ha mostrato ciò con evidenza. Anzi l’impunità e gli sconti di pena funzionano come un vero e proprio rinforzo per tutti coloro che, per una ragione o per l’altra, sono tentati dal crimine. Sappiamo anche che il carcere, quando è solo limitazione della libertà, abbrutimento psicofisico, intento punitivo, anziché avere una efficacia di allontanamento dal reato né ha una esattamente opposta di avvicinamento. In modo particolare sappiamo che i nuovi giunti dalla libertà che entrano per la prima volta in carcere hanno modo di entrare in contatto con il mondo del crimine e che spesso la carcerazione sancisce una vera e propria iniziazione a questo mondo con precise acquisizioni di regole, gerarchie e contatti fondamentali per il futuro. Insomma, il carcere impostato solo in termini punitivi produce come effetto solo l’aumento del tasso di criminalità di una società.
Quindi, il pericolo sociale esiste e non bisogna negarlo o scotomizzarlo ma nello stesso tempo non si può considerare il carcere come una soluzione che risolve il problema. Il carcere contiene solo temporaneamente il problema sociale perchè raramente aiuta chi vi entra. La Legge 354/75 e la 663/86 (Legge Gozzini) partendo più o meno da queste considerazioni hanno compiuto il salto concettuale dal carcere come luogo punitivo a luogo del cambiamento della persona attraverso la rieducazione e la premialità, ma sappiamo che le risorse messe in gioco e i risultati ottenuti sono a dir poco molto scarsi. Il carcere è prima di tutto il luogo dei criminali e della polizia penitenziaria mentre psicologi, assistenti sociali ed educatori sono mosche bianche, gocce nell’oceano con un potere ed un efficacia del tutto marginale. Se il rapporto tra agenti penitenziari e personale coinvolto nell’osservazione e il trattamento è di 50 a 1 ciò significa che il carcere è fattivamente restato quasi esclusivamente un luogo di contenimento punitivo e non di trattamento. La L. 354/75 e la 663/86 hanno innalzato il tasso di civiltà del nostro Paese ma solo scarsamente sul piano teorico ed in modo del tutto insufficiente su quello pratico. Del resto gli interventi prevalenti introdotti dalla riforma dell’ordinamento penitenziario si appellano quasi esclusivamente all’atteggiamento premiale dello Stato italiano e alla speranza di una magica e, oggi lo sappiamo, improbabile risocializzazione. L’attività trattamentale ha da sempre avuto una funzione del tutto residuale, di contenimento e non di cambiamento. Si è trattato fin dall’inizio dell’introduzione di elementi di novità molto deboli ed inefficaci benché l’intenzione fosse rivoluzionaria. Lo spirito della riforma è del tutto condivisibile ma gli elementi teorici e concreti utilizzati sono stati del tutto insufficienti.
In ogni caso il problema della “gestione del criminale” non è solo da porre in termini di rispetto dei diritti di chi ha commesso un reato che certo devono essere rispettati quanto quelli di chiunque altro; deve anche essere posto nei termini della protezione sociale che desideriamo assicurare ai nostri cittadini. E questo è un problema generale che riguarda tutti i detenuti e non solo gli internati. Infatti come potrebbero sentirsi tranquilli i cittadini se consapevoli del fatto che i detenuti e gli internati escono dall’istituto penitenziario avendo sì scontato la pena ma strutturalmente devianti e antisociali come prima se non più di prima? Non molto direi. Pertanto ritengo che il problema sia solo marginalmente quello della certezza della pena che certamente disincentiva ma non modifica la “natura” dell’uomo né il suo impatto sociale. La questione centrale è invece quella del cambiamento strutturale del soggetto criminale. Da questo punto di vista viene a volte sollevata la tesi dell’iniqua e innaturale volontà di ”normalizzazione” dell’uomo che si oppone ad uno stato soffocante. Il soggetto verrebbe deprivato della sua identità e assoggettato al potere dello stato normalizzatore mentre ogni individuo dovrebbe essere libero di individuarsi in modo del tutto singolare e senza limitazione alcuna. In questo momento storico liberista questa idea che ognuno deve essere libero di autodeterminarsi come meglio crede trova il terreno fertile e difficilmente si riconosce che la libertà di ognuno di noi è necessariamente limitata dalla libertà degli altri cittadini. Se non regolate le libertà non possono che entrare in rotta di collisione. Se qualcuno si sentisse libero truffando, ricattando o stuprando il prossimo, è evidente che sorgerebbe un conflitto di libertà. Quindi in un qualche modo la libertà, come la giustizia, deve essere “uguale per tutti” e per esserlo deve essere limitata. Ritengo che la libertà da limitare sia sempre quella di chi in modo prepotente minaccia o viola la libertà altrui. Non ho pertanto alcuna esitazione nel sostenere che tra il legittimo bisogno del cittadino rispettoso delle leggi e il diritto di una nuova possibilità richiesta dal criminale che non ha modificato significativamene il proprio atteggiamento verso la Legge e la società, considero primaria la prima opzione. Questo non significa però dover fingere che certamente un soggetto tornerà a delinquere oppure, successivamente, che certamente la pericolosità sociale è assente. Al contrario esistono solo le posizioni intermedie e, pertanto, probabilità più o meno elevate che la reiterazione del reato avvenga. Tutto sommato neppure rispetto ad un soggetto incensurato possiamo sostenere che la pericolosità sia pari a zero. Il punto quindi non è se c’è oppure no pericolosità sociale ma se è avvenuto oppure no un cambiamento significativo del soggetto rispetto alla Legge e alla società.
Anche a causa della mancanza di una adeguata comunicazione e condivisione teorica tra operatori coinvolti all’interno di questi processi (psicologi, assistenti sociali, giudici, magistrati, educatori, periti, ecc…) gli atti di tutti continuano nella direzione di quanto previsto dalle disposizioni di legge attuali con forzature e reciproche convinzioni e fraintendimenti. Ad esempio i giudici saranno convinti, o fingeranno d’esserlo, che i periti possano effettivamente accertare con precisione scientifica e oggettiva la pericolosità di un uomo così come il perito dovrà fare “come se” ciò fosse possibile riferendo una certezza che in realtà è solo una probabilità non dichiarabile tale. Infatti la credenza della certezza della valutazione della pericolosità sociale costringe gli operatori che lavorano nelle carceri e che si occupano delle attività di osservazione e trattamento, così come i periti che hanno il compito di accertare la presenza della pericolosità sociale, ad utilizzare toni apodittici e a fare “come se” la presenza e/o l’assenza di una qualità, la pericolosità sociale, fosse accertabile con precisione. Al contrario sappiamo che può essere solo ipotizzata probabilisticamente a partire da alcuni elementi dell’osservazione nessuno dei quali è in grado di determinare con certezza il futuro comportamento di un uomo. Non si deve confondere il realismo di un atteggiamento probabilistico con una mancanza di scientificità.2 E’ possibile scientificamente stabilire il tasso di pericolosità di un soggetto all’interno di un orizzonte pienamente scientifico. Se poi l’ipotesi di mancanza di scientificità fosse legata al desiderio di una certezza che non esiste allora saremmo di fronte ad un atteggiamento scientificamente poco rigoroso. Il problema della sicurezza e della protezione mi pare possa essere affrontato in tre modi tutti legittimi ma con potenziali di efficacia molto diversi:
1.temporaneamente allontanando e contenendo il soggetto deviante e antisociale;
2.stabilmente aiutando il soggetto deviante e antisociale a modificare la sua struttura di personalità;
3.in via preventiva evitando che all’interno delle società si producano dei criminali. Il primo modo si ottiene attraverso la detenzione ma ha un’efficacia solo temporanea e non interviene modificando la natura del problema; il secondo modo viene affrontato di seguito nel presente articolo; il terzo modo è il più importante ed implica una approfondita riflessione sulle nostre società che non verrà affrontata nel presente articolo perché ci porterebbe troppo lontano.
Solo dalla sinergia dei tre livelli è possibile attendersi dei risultati accettabili. Diversamente continueremo ad avere esiti totalmente fallimentari. Oggi tutto il problema della sicurezza e della protezione è invece affrontato esclusivamente con il I punto. Ora, anche a partire da quanto esposto in precedenza, mi sembra necessario sottolineare ed evidenziare la presenza di alcune credenze psicologiche che hanno modellato le leggi e l’iter dei percorsi giuridici e penali: 1. la certezza della valutazione di pericolosità sociale; 2. la modificabilità della struttura della personalità dei soggetti immessi all’interno dei percorsi rieducativi e di reinserimento sociale in tempi relativamente brevi 3. la indole o la “tendenza” delinquenziale che se esistesse davvero non consentirebbe alcun cambiamento e quindi nessuna possibilità di revoca della pericolosità sociale. La categoria giuridica del criminale per tendenza che porta ad una misura di sicurezza di 3 anni è un controsenso perché se esistesse il criminale per tendenza sarebbe inutile rivalutare la sua pericolosità mentre invece dovrebbe essergli assegnata la misura perpetua poiché la tendenza non è soggetta a cambiamento. Per quanto riguarda la certezza della valutazione di pericolosità sociale mi sono già espresso in precedenza. Infine, la modificazione della struttura della personalità sarà l’oggetto del prossimo paragrafo.
Modificare la struttura
La pericolosità sociale è una qualità presente oggi ma che è desumibile da ciò che l’esperto valuta possa essere l’azione futura del soggetto esaminato, atto o atti comportamentali che non verranno mai eseguiti proprio per effetto della limitazione della libertà. Da un lato ciò è rassicurante per l’esperto perché nessuno sarà mai nella condizione di dimostrare il contrario, infatti non esisterà mai il futuro all’esterno che dimostrerebbe l’esattezza o la scorrettezza della valutazione. Tuttavia questa situazione è anche molto frustrante per l’esperto perché nulla mai potrà dimostrare la correttezza della sua valutazione e lo costringe all’incertezza e al dubbio perpetuo rispetto ad una decisione estremamente rilevante e invalidante per la vita di un soggetto.
Abbiamo detto che una valutazione del rischio è doverosa ed inevitabile per prevenire tragedie annunciate come quelle di pedofili mai pentiti che appena rimessi in libertà devastano la vita di altri bambini che certo non possono essere sacrificati in nome del nostro buonismo ipocrita. I nostri politici vanno in fibrillazione contemporaneamente in nome del garantismo degli imputati e del lassismo dei giudici indignandosi per colpe che sono solo loro perché sono proprio i politici che devono assumersi l’onere di scelte difficili da trasformare in leggi operative come appunto quella tra garantismo e lassismo. I giudici non possono far altro che applicare le leggi che il legislatore ha varato. I politici sono dei ricercatori di consenso e destinati a tentare sempre la quadratura del cerchio, non prendono decisioni e danno ragione a tutti per piacere a tutti. Bisogna invertire rotta e tornare ad una politica forte che soddisfi delle istanze etiche imprescindibili al prezzo di scontentare qualcuno. Non c’è nulla di male nello scontentare qualcuno, anzi è necessario se si vuole attuare interventi efficaci e trasparenti.
La misura di sicurezza prevede che dopo un paio di mesi di osservazione all’interno dell’istituto di pena si giunga, in ragione delle risorse interne ed esterne dell’internato ed in collaborazione con i servizi presenti sul territorio (legami famigliari, opportunità lavorative, servizi sociali, sert, ecc..), ad un lavoro di tessitura di un progetto da mettere alla prova all’esterno che consenta il reinserimento nel tessuto sociale dell’internato. Molto spesso dai contatti con i servizi territoriali si apprende che è già stato tentato di tutto con il soggetto e che non esistono progetti possibili all’esterno che hanno una ragionevole probabilità di successo. Anzi, la carcerazione e l’internamento sono spesso vissuti dagli operatori del territorio come una “soluzione” che consente a tutti di prendere fiato e tirare un respiro di sollievo. Spesso anche le famiglie già molte volte tradite e deluse non sono disponibili a concedere ulteriori aiuti. Molti internati non hanno una casa, dei legami affettivi e delle relazioni significative, non hanno un lavoro, ecc… Paradossalmente gli unici che riescono rapidamente a porsi nelle condizioni di articolare un progetto che ha una parvenza di consistenza (casa, famiglia, proposte di lavoro, disponibilità, ecc..) sono gli internati in odore di mafia e affini. Dico paradossalmente perché al di là delle apparenze e delle “risorse oggettive” a disposizione sono i soggetti nella sostanza ovviamente più pericolosi socialmente. Insomma in molti casi non è possibile articolare un progetto di alcun tipo, spesso i progetti falliscono nell’arco di poche settimane, sono delle assolute rarità i percorsi che vanno in porto. Cosa significa? In primo luogo che un progetto di reinserimento messo insieme nell’arco di pochi mesi e fondato su elementi meramente concreti come il lavoro e un posto dove dormire con dei soggetti che hanno vissuto una vita disastrosa da tutti i punti di vista, è un progetto estremamente debole.
In secondo luogo non c’è niente che può modificare un soggetto se questo non ha deciso di cambiare la propria vita. Non si può nulla senza la motivazione.
Quindi c’è una questione temporale, una questione concernente l’impiego di tempo in esperienze formative significative e una questione di riposizionamento del soggetto in relazione alla Legge e al mondo umano. Solo attraverso la sinergia di interventi integrati che coinvolgono contemporaneamente i due livelli sopra indicati è possibile elevare le probabilità di azioni efficaci a sostegno dei soggetti internati. Attualmente nessuno dei due livelli è contemplato dalla normativa vigente e, di conseguenza, non ha alcuna applicazione concreta.